Il Manifesto di Ventotene è la nostra Europa
di Maurizio Merlo
20 marzo 2025, la Presidente Meloni interviene alla Camera dei Deputati affermando: “Il Manifesto di Ventotene non è la mia Europa!”. Lo fa estrapolando poche frasi dal testo, con riferimento a due punti in particolare: la cosiddetta dittatura del partito europeista rivoluzionario, e il regime della proprietà privata.
Critiche di cui proverò a dimostrare l’inconsistenza, il Manifesto è d’altronde considerato ancora oggi in Europa, in tutti gli ambienti politico-culturali, documento primiero e fondamentale per la costruzione di un’Europa unita e federalista, e il fatto che la Presidente Meloni non consideri il Manifesto appartenente alla sua cultura dovrebbe essere fatto noto e non destare scandalo, se e in quanto non sia stata dimenticata la sua scuola politica e culturale.
Il Manifesto fu elaborato dagli antifascisti italiani Spinelli, Rossi, Colorni ed altri, a Ventotene nel 1941. Vivevano sull’isola in regime di confino politico, infuriava la seconda guerra mondiale e la Germania nazista aveva il controllo dell’Europa continentale.
Esaminiamo i due punti di critica meloniana.
Sulla questione dittatura del partito europeista rivoluzionario, effettivamente poco coerente con i valori democratici del documento, gli stessi autori ebbero modo successivamente di chiarire quella posizione estremizzata, spiegandola con il clima di quegli anni, la coscienza del fallimento delle democrazie parlamentari negli anni ’20 e ’30, il consolidamento delle dittature, la difficoltà di concepire la lotta ai nazionalismi totalitari al di fuori di uno schema violento di azione politica e militare, contrapposto alla violenza di quei regimi. Esaminata in questo quadro emerge la prospettiva storica di Ventotene ’41 che è democratica, liberale, socialista, antifascista, europeista.
Poi la riconquista di democrazia e libertà, dopo anni di fascismo, avvenne necessariamente dentro una sanguinosa guerra civile, una profonda lacerazione del tessuto sociale, civile e politico. Contesto che il Manifesto esprime nell’ideazione di una dittatura democratica che si organizza per combattere fascismi e nazionalismi, in cui la prospettiva della vittoria contro quelle dittature non poteva che essere guerra e violenza, fra flebile speranza e passione civile, e spirito di resistenza, fino al carcere e al sacrificio della vita. Ricordiamo il sacrificio di Eugenio Colorni (filosofo e sostenitore del federalismo europeo) che pagò con la sua vita, ancor giovane, ad appena 34 anni, l’impegno politico. Era il maggio del ’44, era stato consegnato dai fascisti alle truppe del Terzo Reich.
Difficile insomma, a quei tempi, ideare l’uscita dal nazifascismo, in Italia come in Europa, senza una rottura violenta e militare, la politica non bastava, occorreva una dittatura contraria e opposta alle forze del male.
E andiamo al secondo punto della critica: il regime della proprietà privata.
Cosa afferma il Manifesto?
“La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio”, ma questa affermazione è immediatamente successiva ad un’altra:
“Il principio veramente fondamentale del socialismo, e di cui quello della collettivizzazione generale non è stato che una affrettata ed erronea deduzione, è quello secondo il quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma - come avviene per forze naturali - essere da loro (gli uomini, le masse popolari, ndr) sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne siano vittime”.
Questa idea di una proprietà privata libera ma nei limiti dell’interesse generale e del controllo pubblico non è altro che l’anticipazione del progetto che prende corpo nel 1948 nella nostra carta costituzionale, il grande patto nazionale fra cattolici, liberali, azionisti, socialisti e comunisti, spesso definita la costituzione più bella del mondo, proprio per questa capacità di portare a sintesi un progetto che vedeva incontrare i più alti valori di culture politiche diverse, nella ricerca di una possibile armonia fra libertà e socialismo, fra forma e sostanza di un sistema democratico avanzato.
Si leggano in tal senso gli artt. 3, 41 e 42 approvati all’Assemblea Costituente in materia di principio di eguaglianza, di definizione di libertà dell’iniziativa economica, di definizione di proprietà pubblica e privata (dal ’48 fra i principi fondamentali della nostra Costituzione): tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge; l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; la proprietà privata è libera, ma nei limiti della sua funzione sociale e nella garanzia del libero accesso.
Oggi, l’atteggiamento sufficiente di chi non vive come propria la conquista e la difesa della democrazia dichiarando “La Costituzione non è antifascista”; di chi vive per formazione la democrazia come passaggio opportunistico; come occasione di un momento di crisi per la presa del comando misconoscendo contenuti e principi della nostra Costituzione; di chi tollera la classe politica sconfitta alle elezioni e la considera esterna alla dialettica democratica, ai margini del sistema, dove debba stare in attesa di future, eventuali, elezioni; di chi considera gli altri poteri dello Stato (legislativo e giudiziale) come accompagnatori dell'attività di comando ("attività di governo" significa altra cosa secondo un linguaggio di democrazia liberale); atteggiamenti tutti che costituiscono un brodo sottoculturale sovranista e nazionalista, dichiaratamente afascista e di formazione fascista. Da tutto questo nasce la comprensibile difficoltà addirittura a leggere "Il Manifesto di Ventotene".
La Presidente Meloni, in ordine ai punti di critica radicale al Manifesto di Ventotene, sollevati alla Camera dei Deputati, compie una mera provocazione (respinta in questi giorni dallo stesso mondo conservatore liberale europeo) che coincide con una presa di distanza dai valori della nostra costituzione antifascista. Ed infatti le idee di sovranismo, nazionalismo, afascismo, sono assolutamente incompatibili con i fondamentali della Costituzione repubblicana, e sono altresì assai distanti da un progetto di Europa federale.
Meloni ha detto la verità: “Il Manifesto di Ventotene non è la mia Europa!”.
“Ci era oltremodo chiaro!” osiamo chiosare.
Ma oggi è necessario replicare che né il Manifesto di Ventotene, né la nostra Costituzione repubblicana sono in svendita, detti testi sono legati da una storia comune che è la storia dell’antifascismo, della resistenza, delle lotte per la democrazia. Entrambi i documenti nascono dalla lotta contro la stessa tragedia e contro la stessa barbarie.
Il Manifesto va letto da tutti, è un documento ricco di storia e di cultura politica ed economica, ancora oggi visionario, ambasciatore di verità realizzate e di molte altre ancor oggi da realizzare. E per promuoverne la lettura scelgo due stralci significativi, ricordiamo ancora, era il 1941! I nostri eroi vivevano in regime carcerario, e il nazismo dominava un’Europa a ferro e fuoco, senza diritti, senza libertà, con Paesi occupati arbitrariamente occupati, con la persecuzione e lo sterminio razziale di un popolo:
“Un’Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l’era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era sarà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali.”
“… bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l’unica garanzia concepibile che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità politica dell’intero globo”.
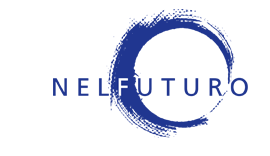
 Clicca qui per ascoltare
Clicca qui per ascoltare 
